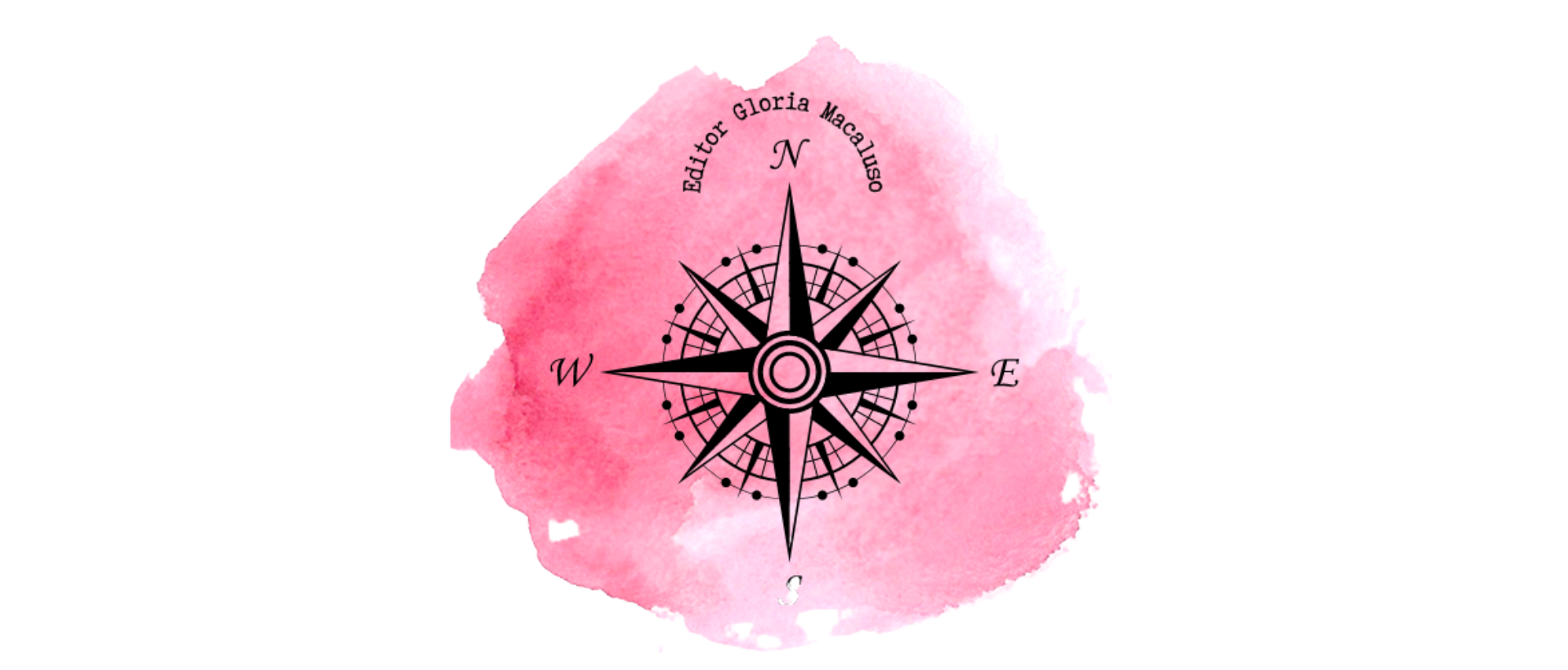16 febbraio 2024
È mattina presto. Mi sono imposta di fare una camminata lungo il fiume, anche se pioviggina. Poco male, mi dico, la piega ai capelli la faccio domani. Infilo la borsa al braccio, avvolgo la sciarpa sotto il mento e lascio a casa l’ombrello, che mi pare porti sfortuna. Sono dieci minuti a piedi fino al bar; un caffè, sorrisi mesti e secchi, pago ed esco. Costeggio il muretto diroccato che affaccia sull’Olona. Il fiume è placido; le solite papere nere e qualche guizzo sotto il pelo verdastro dell’acqua – io mi ostino a pensare siano castori, ma è più probabile si tratti di alborelle.
Torno indietro, questo venerdì mattina ho un’intervista. Stefano tarda qualche minuto. Mi avverte, e io ne approfitto per un secondo caffè, stavolta casalingo, e l’ultima sigaretta prima di mettermi seduta davanti al pc. Ho preparato alcune domande, ma non sono sicura di volerle porre tutte, dopo le prime risposte me ne verranno fuori di più interessanti, capita quasi sempre così. Accedo a Zoom, lancio la riunione (me lo immagino proprio questo lancio: un acceleratore di particelle che viaggia da qualche parte nell’iperuranio del mondo-internet) e sullo schermo appare il viso di Stefano Izzo, editor di narrativa italiana e direttore della collana Le Stanze, per Salani Editore. Progettavo di contattarlo da dicembre, ma farlo durante il periodo delle vacanze di Natale mi sembrava scortese. Non credo di essermi comportata meglio mandandogli una mail nel mezzo della settimana del Festival di Sanremo. Ma Stefano è da subito cortese. Ci salutiamo, dice che anche lui ha preso il caffè del ritardo. Lo ringrazio per questa possibilità, e gli annuncio che ho studiato molte delle sue precedenti interviste. Sono informata su chi sei, gli dico. Suona come una minaccia, lo so. Ma Stefano risponde: Mi fa sempre ridere questa cosa, allora mi consolo all’idea di non essere l’unica.
G: Se non vado errata, questo è il quarto anno in cui dirigi la collana Le Stanze di Salani. Vorrei partire da qui. Di cosa si occupa? Cosa ti auguri di portare al suo interno?
S: Quando sono arrivato alla Salani, nel 2020, per volontà di Luigi Spagnol, la casa editrice aveva il progetto di ampliare la produzione adulta, che esisteva già – Salani negli anni ha sempre pubblicato libri adulti, ma forse in maniera non così sistematica. Ci siamo interrogati per mesi su che cosa dovesse ospitare questa nuova produzione. Le possibilità erano molte: una narrativa più commerciale o letteraria? Un singolo genere o no? E la grafica doveva essere rigida o adattarsi di volta in volta? E in quale fascia di prezzo e di mercato volevamo posizionarci? Soprattutto ci siamo interrogati su che cosa dovesse essere: una collana stretta oppure un contenitore più ampio? Abbiamo risolto per la seconda opzione.
Potrei fare dei paragoni [e aggiunge: forse impropri], ad esempio con le Strade Blu di Mondadori, la mitica collana creata da Edoardo Brugnatelli; oppure con Stile Libero [Einaudi], che nasce come ampio terreno di esplorazione. L’idea delle Stanze era proprio quella: uno spazio aperto, arredabile di volta in volta, un posto accogliente per autori e per lettori. Non era un nome da collana [mi rivela un altro nome, l’opzione vagliata in precedenza], ma Le Stanze dà l’idea di un luogo modulabile, un concetto che ci piaceva molto.
Cosa metterci dentro? Io ho sempre fatto un po’ di tutto: ho lavorato per tanti anni in Rizzoli e per un periodo più breve in DeAgostini e ho avuto la possibilità di lavorare con grandi autori letterari, con i giallisti, con romanzi più smaccatamente commerciali, i memoir, i rosa. Un po’ di tutto: esordienti, autori medi, “grandi vecchi” e bestseller. Mi è sempre piaciuto fare cose molto diverse e credo che in un segmento come quello che si stava creando [Le Stanze] avesse senso questa sperimentazione, ti evita di cadere nell’automatismo. Non sono un fan dei libri in serie, anche se per una casa editrice possono rivelarsi una forza, una volta trovato il filone giusto; viceversa, se questo filone non lo azzecchi, è come se ti fossi infilato da solo dentro una gabbia. Insomma, nella creazione della collana c’era un calcolo: proviamo a fare tante cose e diverse, lavoriamo i libri in maniera unica e capiamo anche che cosa riusciamo a fare meglio, cosa dà risultati migliori, cosa ha più senso per il mercato. Teniamoci aperti ed eclettici, una caratteristica che la Salani ha già nel suo Dna, peraltro, da 162 anni. Tant’è che, alla fine, è andata così.
Un caso che posso citare e che fa esplodere questo concetto si è verificato lo scorso anno con la biografia di Michele Ferrero [un libro che inseguivo da anni, aggiunge] che, di fatto, è una biografia-saggio di stampo classico. Avevamo delle aspettative su questo libro, e le ha disattese tutte, ma in senso positivo: è andato primo in classifica nella settimana di uscita e in quella stessa settimana ha venduto il novantacinque per cento delle copie che erano state stampate. Era una storia che nessuno aveva mai raccontato, ed erano una persona, un marchio e un’azienda molto amati.
In fondo, la dimensione dell’interesse del pubblico non la si conosce mai, e il fatto che si trattasse di un saggio ci ha obbligato, da quel momento in avanti, a ragionare sull’ampliare in quella direzione di ricerca la produzione delle Stanze. Tra qualche mese uscirà un saggio sulla storia della Lego, e qualche settimana fa ne abbiamo pubblicato uno sul Teatro Ariston di Sanremo. Insomma, forme ibride fra la narrativa, la saggistica e la biografia. Cose che a me piacciono particolarmente.
Le Stanze, in definitiva, sono un contenitore ampio, dove per fortuna ci concediamo la libertà di innamorarci dei libri migliori che troviamo. Cerchiamo di abbracciare la varietà e al tempo stesso di dare una coerenza, un’identità al catalogo: una delle cose per me più importanti. Ma nel 2024 non è così semplice.
Identità: è così difficile trovarla, o forse non è possibile; forse, l’identità è qualcosa che si costruisce, che non si può determinare a priori. E poi penso alla parola libertà. Nel mondo-libro è sulla bocca di tutti, ma nelle mani di pochi. Ci penso un attimo prima di chiederlo a Stefano.
G: La libertà di innamorarsi dei libri, per chi i libri li fa, non è così scontata.
S: No, non lo è. Gli scontri sul gusto e su questa libertà, in casa editrice, si svolgono quotidianamente. È anche il bello. Quando leggo un romanzo penso al mercato, certo, e ho delle linee guida più o meno affidabili, ma poi a muovermi è il gusto: decido che mi piace e che lo voglio presentare. Penso piaccia anche agli altri, ma non posso esserne sicuro: l’unico vero collaudo di un libro è quando esce in libreria. Per questo ne parlo con i colleghi, con il direttore editoriale, con altri editor, con l’ufficio stampa [penso alla parola confronto, è fra le mie preferite]. Ci si può accorgere di aver preso un abbaglio, oppure tirare dritto per la propria strada, portare avanti la propria idea. È anche divertente, ma la libertà è una cosa complicata. A volte ti fa sentire perso: sei libero di scegliere e quando lo sei senti anche la responsabilità dello sbaglio. Lavoro da tanti anni e ad oggi vivo la bellezza di sbagliare con più serenità perché mi è chiaro che devo sbagliare se voglio ottenere dei risultati. La cosa importante è farlo in maniere sempre nuove [perseverare è diabolico, no?], e non rimanerci male se scopri che qualche libro in cui credevi tanto in realtà piaceva solo a te, oppure lasciarti sorprendere da scelte che avevi fatto con più leggerezza e che invece si sono rivelate favorevoli. Da questo punto di vista sono fortunato: la Salani è fatta di persone e da una cultura, che ci precede tutti, di grande apertura mentale. Ovvio poi che anche noi guardiamo al mercato e trascorriamo le ore a parlare di piani marketing, non siamo fatti di sole immagini poetiche.
È l’altra faccia dell’editoria, mi dico, e se non ci siamo dentro ce ne dimentichiamo spesso. Non solo profumo di cellulosa e inchiostro fresco, ma anche promozione, marketing: soldi. Non è vil denaro, bisogna pur campare. Do uno sguardo alla lista che ho preparato: voglio domandare di più dell’oggetto-libro.
G: In un’altra tua intervista – te l’ho detto, ne ho lette molte – parlando dei tuoi esordi e del felice incontro con Stefano Magagnoli, hai detto che il tuo interesse per la narrativa e il mondo editoriale nasce anche da una volontà di smontare l’oggetto-libro e osservarne da vicino i componenti. È una metafora bellissima, ingegneristica. Esistono queste componenti oggettive da poter valutare?
S: Esistono delle logiche. [Premessa, aggiungo, parafrasando la sua espressione]: io non mi ritengo uno studioso di narratologia. Non ho mai studiato con attenzione un manuale di narratologia né ho fatto corsi di scrittura, né mi sento un insegnante di scrittura [non posso che storcere il naso: paladina dello studio critico, della narratologia, degli espedienti!, ma sono affascinata]. Non so come si costruisce un libro in maniera infallibile. Se lo sapessi… intanto non lo direi a nessuno, anzi: sarei autore io stesso e comporrei la macchina per diventare ricco e famoso [sorride, e anche io]. Eppure, sotto tanti aspetti, è vero che il libro si smonta. [Solleva un libro, lo riconosco dalla copertina, è Demon Copperhead di Barbara Kingsolver]. Quando iniziai a interessarmi al mondo-libro, la fisionomia che i titoli assumevano attraverso il lavoro editoriale mi sembrava la più naturale possibile. Intorno a questo oggetto [solleva ancora Demon Copperhead, lo vedo sfocato attraverso l’effetto di Zoom] non c’è solo il testo, frutto del creatore, ma tanto altro: la copertina, il titolo, il formato, la cartotecnica, il prezzo, le comunicazioni… Da normale lettore, il mondo dietro il libro lo intuivo, e intuivo che c’era una distanza fra il prodotto grezzo, il testo, e quello che potevo acquistare in libreria. È qui che sta il lavoro dell’editore, in questo territorio di mezzo.
Stefano mi racconta che, piano piano, muovendo i primi passi nel mondo editoriale, si inizia a capire quanto lavoro esista dietro la pubblicazione di un titolo. La copertina, come può essere pensata, come può cambiare; i prezzi, e cosa cambia da un prezzo all’altro; il titolo, la dimensione, le alette…
S: Il publishing, l’insieme di tutti questi ragionamenti, ha sì delle logiche, degli elementi che possono essere studiati, calibrati e modulati di volta in volta. Ma il lavoro sul testo lo vedo meno tecnico. È molto più legato alla soggettività degli autori; aiutarli a tirare fuori l’imponderabile che hanno dentro [mi piace molto questa immagine, questa scelta di parole]. Per esempio, agli autori do raramente suggerimenti specifici sulla tecnica, però posso consigliare loro che cosa evitare per “non farsi del male” nel mercato editoriale. Oppure aiutarli a tirare fuori qualcosa che vedo vorrebbero tirare fuori, ma che non sono ancora riusciti a individuare. La tecnica è più sul publishing che sul lavoro sul testo, o lo è nella mia predisposizione mentale. Di fatto, il lavoro editoriale è un’interpretazione, la personalizzazione di una creatività altrui, un valore aggiunto che si dovrebbe sposare nella maniera più armonica possibile con il lavoro dell’autore. Il libro deve essere pensato non solo al suo interno, ma anche intorno.
G: Quante mani servono, allora, per fare un libro?
S: Tante [ci pensa, anche io]. Dipende dalla struttura della casa editrice. Potrebbero bastare quelle dell’autore. Ci sono tanti editori, anche grandi, in cui il lavoro editoriale è meno collaborativo e assomiglia più a una “catena di montaggio”. O ci sono case editrici molto piccole dove una o due persone fanno tutto, dall’amministrazione all’ufficio stampa.
Per esempio, nella struttura di Salani le mani sono molte. Ci sono le mie, quelle del direttore editoriale, dell’amministratore delegato, dell’ufficio stampa, del marketing, della rete commerciale. Decine di persone. Poi c’è la redazione, che tra me e me chiamo, con il massimo rispetto, “la sala caldaie”: se non ci fossero quelle persone “oscure”, che con grande dedizione fanno in modo che i libri escano, noialtri non potremmo banchettare nel salone delle cerimonie. La mia riconoscenza nei loro confronti è massima.
Persone oscure, ché il lavoro editoriale, diceva qualcuno, non deve lasciare traccia. Anche se non è sempre così. Mi viene in mente un’altra domanda.
G: Potenzialmente, secondo te, se tu fai un editing su un libro, e poi passi il libro a un altro professionista, lui o lei potrebbe fare un altro lavoro punto e a capo?
S: Forse succede. Potenzialmente può succedere. Ma due editor, due persone che fanno un editing nella forma, nella sostanza e nelle idee dell’autore… secondo me fanno danni. L’editing è un’interpretazione personale. Nella mia impostazione tende a essere il più possibile armonico con l’intenzione dell’autore, non ne aggiungo una nuova. È ovvio, però, che anche io ho una personalità, i miei gusti, le mie idiosincrasie; le influenze che il mondo esterno ha su di me e che io ho sui testi. Ci metto del mio, anche quando cerco di non farlo [è inevitabile, no?]. Se arriva un altro, rischiamo di essere in contraddizione: e l’autore a chi deve dare retta? Fa comodo che un autore si senta spaesato? Se parliamo di editing, secondo me parliamo di un rapporto a due.
Mi viene da pensare a questo rapporto a due. In quali altre occasioni ci ritroviamo a quattr’occhi? Nella coppia, con l’amica del cuore, dallo psicanalista.
S: La fiducia può essere tra due persone. Non riesco a pensare a un ménage à trois. Di solito, svolgo l’editing personalmente, poi passo il testo alla redazione [la sala caldaie]. Se la redazione vede dei problemi o degli errori – cose che non sono pura formattazione o refusi o piccole revisioni – bussa da me. “Ste’, abbiamo visto questa cosa, che facciamo?” A quel punto ci rimetto mano e mi interfaccio con l’autore. Se ci fosse un altro editor, rischieremmo che chi viene dopo di me “smonti” ciò che ho fatto io. E a quel punto che senso avrebbe?
Riflettiamo per qualche altro minuto sulla potenzialità di questo “doppio lavoro”. Gli dico che l’editing potenzialmente infinito è un rischio, sì, ma è anche la dimostrazione di quanto sia soggettivo il lavoro sui testi. “Se un editing lo faccio io e poi lo fai tu, il romanzo potrebbe cambiare faccia”, gli dico. “Sì, c’è questo rischio. La componente soggettiva c’è sempre, anche nel momento in cui io cerco di armonizzarmi con la volontà dell’autore, quella stessa volontà non è unica o scolpita, devo provare a darle voce: la intuisco, cerco di afferrarla, la intravedo… ma sempre dal mio punto di vista”, mi conferma.
S: La verità degli autori, spesso, non la sanno neanche loro. Non perfettamente. A me, per esempio, piace molto fare domande, ascoltarli prima di lavorare sul testo [il corsivo di prima è mio, mi sembra importante sottolinearlo]. Quando fai domande agli autori capisci quale e quanta è la distanza fra ciò che l’autore voleva fare e ciò che effettivamente ha fatto. E questo doppio piano, cioè “cosa hanno fatto” e “cosa volevano fare” delimita lo spazio entro cui lavorare. Devi cercare di avvicinare il più possibile le due cose.
Due piani, due punti che non dovrebbero trovarsi troppo distanti, altrimenti lo spazio da colmare sarebbe eccessivo, troppa libertà di movimento, forse, troppo terreno di gioco.
G: Quindi, passando da un libro all’altro, da un autore all’altro, è come se anche tu dovessi calarti in vestiti diversi, indossare nuovi e vecchi abiti. Cambi il tuo approccio, per farlo?
S: È la cosa più bella. Io cerco di sparire, devo diventare temporaneamente qualcun altro. Devo tentare di capire un’altra persona, di capire l’opera da dentro l’altra persona. E devo pensare a proposte, sul testo o su elementi paratestuali, che rispecchino quella visione, il suo punto di vista. Questo fa sì che si abbia a che fare con personalità differenti, testi differenti: devi lavorare sulla tua capacità camaleontica, ma anche psicologica di empatia… [Parte un oh! alla romana, prefazione della prossima frase – una trasposizione fedele potrebbe essere: insomma, è una verità scomoda ma è una verità]: ci sono persone che ti stanno simpatiche a pelle, così come ce ne sono di molto diverse da te. Con gli autori che, magari, hanno la mia stessa età, o con la quale condivido interessi simili, è più semplice trovare un feeling, e quindi è più semplice “impossessarsi” delle loro voci. Lo sforzo è maggiore, invece, quando ci sono caratteri differenti. Però è sempre bello, perché ti confronti con tante persone. Gli scrittori [ride] sono dei grandissimi rompiscatole, ognuno a modo suo. Però ti danno tanto. Nel fare un pezzo di strada con loro prendi tanto di diverso che ti porterai dietro e che a volte si sedimenta dentro di te.
G: In un’intervista hai detto che sono creature fragilissime e tiranniche. È una scelta di parole perfetta. Intanto il termine “creature”, che dà già l’idea di qualcosa di sovrumano, e poi due aggettivi così in contrasto e così precisi.
S: Ci sono giorni in cui fai difficoltà. Ti svegli alla mattina alle otto e ci sono già tre o quattro messaggi. Pietà! Oppure la domenica, il sabato. Tu gli dici: “guarda, oggi non posso, sono incasinato, sentiamoci con calma tra due o tre giorni”. E loro continuano a scriverti. “Ma non ti ho appena detto che sono incasinato?”
Sorridiamo, ridiamo. Creature fragilissime e tiranniche: non lo siamo un po’ tutti con le cose che amiamo?
S: Un’altra definizione, forse l’ha data Lagioia: “gli scrittori sono dei vampiri”. Ti succhiano tutto ciò che tu hai da dare: ne hanno bisogno, non è cattiveria. Allo stesso tempo, anche noi siamo vampiri: mentre loro reclamano, lo fai anche tu. Prendi idee, intelligenze, sensibilità, competenze, storie, conoscenze. È questo il punto: ti arricchisci. Lo dicevo prima: per un periodo diventi loro, ma quando torni te stesso, quando il lavoro è finito, prima di tutto un po’ ti mancano. E, secondo, non sei più il te stesso di prima, hai portato via qualcosa, c’è qualcosa di diverso. Anche una piccolezza.
Ci rifletto un istante, mentre Stefano raccoglie dalla memoria un esempio da portarmi. È come quella abusatissima citazione: “Quando finisci un libro e lo chiudi, dentro c’è una pagina in più. La tua.”
S: Anni fa ho avuto la fortuna di lavorare con Sebastiano Vassalli. Lui usava tantissimo i due punti. Aveva una logica di pensiero e quindi di scrittura in cui molte frasi avevano i due punti a metà. A me sembrava che appesantissero, che fossero anche strani, quindi tendevo a toglierli dal testo. Poi lui mi disse, da dolcissimo burbero: “Non ci è riuscito Giulio Einaudi a farmeli togliere, non credo ci riuscirai tu” [sorride, e spolvera le mani l’una contro l’altra: nulla da fare, arrendiamoci]. Tutt’ora, quando scrivo, uso i due punti molto più di frequente e lo faccio, con le debite proporzioni, nella maniera in cui li usava lui, perché ho capito il meccanismo interno che c’era dietro il loro utilizzo. Quando scrivo, quindi, c’è in me un po’ di Sebastiano Vassalli. Come di tanti altri scrittori.
Impari tanto. Anche dal contenuto. Espressioni che non si conoscono, espressioni dialettali, tradizioni. È come spiare una parte di una conoscenza altra. La questione dei due punti mi stuzzica una domanda più tecnica.
G: Tornando al testo, quanto è importante, dopo il tuo lavoro di editing, il lavoro della redazione? I correttori di bozze, i revisori.
S: Sono fondamentali. Il loro lavoro è la nostra assicurazione. Io ho un paio d’occhi, e con lo scrittore siamo a due paia. Noi abbiamo letto e riletto il libro molte volte, rimasticato, e non abbiamo più nessuna distanza; a un certo punto ti rendi conto che non si può più spingere, non c’è più terreno di lavoro: siamo arrivati al nostro limite. La redazione è la tua assicurazione. E se è una brava redazione sai che c’è qualcun altro che ti copre le spalle, farà il miracolo di lavorare in tempi stretti, di consegnare entro la scadenza prevista. Tutto il mestiere editoriale tende all’inconsistenza pubblica, e la redazione si occupa del “lavoro sporco”: controllare il lavoro di chi è arrivato prima.
G: Non è solo un lavoro di correzione di bozze.
S: No. Anche se dipende molto dal testo e dal tempo che si ha a disposizione. Quando passo un testo editato alla redazione comunico l’impressione che ho avuto io sulle cose che possono ancora essere migliorate, oppure su cose da non toccare – come i due punti di Vassalli. Ci sono libri particolarmente puliti sui quali la redazione deve intervenire poco, oppure altri in cui trovano qualcosa da potenziare, e se c’è tempo lo si fa. La casistica è ampia.
Penso al lavoro minuzioso delle redazioni, e torno indietro di qualche minuto, a quando Stefano ha detto di non aver studiato narrativa. Quando entro nelle redazioni, quando sto con le mani sulla tastiera, non posso che pensare allo studio, alla critica, alla scrittura non solo come talento. E allora glielo chiedo.
G: Hai detto che non hai studiato narrativa. Mi ha stupito [sorride, forse sghignazza: non dovrei dirlo!, ma rassicuro: vengo in pace]. Mi interessa, invece, perché non ti è richiesto saper scrivere come i tuoi autori [non è detto che non sappia farlo, mi dice, sono d’accordo], però ti è richiesta una certa capacità di lettura. Anche se non conosci il nome del tal un “principio narratologico”, la definizione della tal altra “struttura” eccetera, le sai comunque riconoscere.
S: Certo. L’editor è prima di tutto un lettore. È anche un tecnico della scrittura, ma deve essere essenzialmente un lettore. [Premessa, aggiungo io, sempre interpretando il tono del discorso]: io ho tre datori di lavoro: uno mi paga lo stipendio, ed è l’editore; uno è l’autore, in funzione del quale mi dedico tutto il giorno; e uno è il lettore. Devo tenere presente tre volontà: quella dell’editore, quella dell’autore e l’interesse del pubblico, e questo interesse lo faccio se rimango lettore a mia volta, mettendomi nei suoi panni. Il lettore non è un tecnico, ma qualcuno che reagisce alla scrittura. Nel lavoro sul testo, per me è molto più importante sentire, con un organo che non ha un nome [solleva le spalle, non c’è una definizione].
Sentire, sensibilità. Faccio un gesto con le mani, sfregando il pollice sulle altre dita: sentire qualcosa.
S: Quando tengo dei corsi in cui cerco di spiegare cos’è l’editing, parlo della prima lettura, che fai per conoscere il libro. È la più importante, quella in cui non sai ancora nulla e non sei influenzato da nulla, quindi reagisci al testo. E non è una reazione analitica, ma istintiva: mi annoio, mi diverto, mi eccito, provo disgusto… ho delle sensazioni. È fondamentale registrare queste sensazioni: presumibilmente, saranno quelle del pubblico. Un buon editor dovrebbe rappresentare non solo sé stesso, ma anche una sorta di super-lettore attraverso cui anticipare le reazioni non solo di chi gli somiglia, ma anche di chi gli è diverso. Per me è più importante dire a uno scrittore: “dal capitolo otto al capitolo dieci c’è qualcosa che non va, non accade nulla, mi annoio: troviamo una soluzione”. Inoltre, penso che un approccio scolastico, quello che può derivare da un manuale, non funzioni nella maggior parte dei casi. A me non interessa fare lunghe disquisizioni sul narratore onnisciente e simili, io parlo di reazioni.
G: Seguire pedissequamente le regolette da manuale genera un appiattimento visibile. Si vede, si sente, lo dico anche da lettrice.
S: C’è anche un altro aspetto. Io, rispetto ai miei scrittori, dove sono? Al pari, più in alto o più in basso? Sono un insegnante, sono al loro livello o sono più in basso, intimidito? Di solito, all’inizio della carriera editoriale si tende a relegarsi più in basso – soprattutto di fronte a scrittori di grande calibro, come è capitato a me i primi tempi. Ma l’obiettivo finale è mettersi di fianco a chi scrive, e quindi avere la consapevolezza che su alcune cose ho “ragione” io (che ho un certo tipo di esperienza, anche di mercato), e su tante altre cose ha “ragione” lo scrittore. Devo riconoscere il suo primato e la sua particolarità: se iniziassi a infilare nozioni da manuale non solo gli toglierei identità, ma non riconoscerei più il suo valore. Questo è l’errore più grande: se lavori con uno scrittore devi avere fede nel suo talento. Poi, sì, noi indirizziamo e spingiamo a fare meglio, ma non ci mettiamo in cattedra, su un piedistallo. E questo approccio, al contrario, lo vedo in molti editor o di scarsa esperienza o che non hanno esperienza all’interno delle case editrici. Secondo me, gli editor di casa editrice mettono molto meno “i piedi in testa” rispetto a quelli esterni. [Precisa:] Esprimo questo giudizio avendo la fortuna di lavorare in una fase di solito successiva rispetto a quella degli editor esterni, con testi già abbastanza conformati e con autori che hanno una consapevolezza di sé maggiore.
Ci penso un attimo, e mi ritrovo nelle sue parole. Tanti editor inesperti o che non hanno mai collaborato con realtà editoriali hanno la tendenza ad applicare regole e a seguire dettami identici per ogni storia, stampi ripetuti come ex libris in ogni singolo romanzo. Mi chiedo se il motivo sia da ricercare nella mancanza di confronto con altri professionisti. O nella mancanza di quella “assicurazione” che è la redazione, la sala caldaie, come la chiama Stefano, o in generale di tutta la macchina editoriale, della sua mediazione.
G: C’è chi dice che l’editor, per poter fare il suo mestiere, per lavorare i testi degli altri, certificato di credibilità!, debba per forza scrivere. Anzi, debba per forza pubblicare qualcosa. Tu cosa ne pensi?
S: Non so chi lo dice, ma non sono d’accordo. Nel mio cellulare, tempo fa, ho aperto una nota intitolata “Editor scrittori” in cui ho segnato, nel corso del tempo, editor che diventano scrittori (o scrittori diventati editor). Sono tanti, decine. È un costume, ma non solo contemporaneo. Prima che esistessero gli editor – diciamo prima degli anni Ottanta – le persone che svolgevano la funzione più simile alla nostra erano i famosi consulenti letterari. Giornalisti, scrittori: persone che avevano già una loro scrittura, che partecipavano al dibattito pubblico. [Stefano storce il naso, un po’ si agita sulla sedia, e vedo tremolare lo sfondo annebbiato della videochiamata] Ti viene un po’ la tentazione di scrivere? Sì, certo. Hai sempre le mani dentro le parole, e a un certo punto ti viene voglia di giocarci: hai la sensazione di poter fare qualcosa di buono e di poterti anche divertire. Puoi capire se quella sensazione è troppo forte, e quindi sfogarla, o capire se è gestibile o addirittura posticcia. Per esempio, essendo io prevalentemente editor di narrativa difficilmente scriverei un romanzo: mi andrei a sovrapporre ai miei autori. E non è possibile trovarci in competizione, sotto tanti punti di vista. Lo troverei sbagliato. Per loro, specialmente. Forse gli verrebbe il dubbio che lavorando ai loro testi io possa imporre la mia poetica – e se ce l’avessi, una poetica narrativa, che per fortuna non ho e che non voglio sviluppare, farei difficoltà a tenerla a bada. E se il mio libro vincesse qualche premio? Sarei ancora un complice o diventerei un concorrente? E il mio editore come la vivrebbe se pubblicassi un libro per un altro marchio? Sono dinamiche pericolose. Allora, se proprio dovessi scrivere, scriverei qualcosa che non c’entri nulla, non narrativa.
G: Useresti uno pseudonimo?
S: No. Prima di tutto, secondo me non funzionano. E, inoltre, la scrittura è sempre un atto esibizionistico: tu pubblichi perché vuoi esistere di più. Pubblicare con uno pseudonimo non ti fa esistere, ti fa solo rosicare [ride, mi accodo].
G: E una tua ipotetica pubblicazione potrebbe mai essere un metro di giudizio per la tua capacità di editare i testi altrui?
S: Assolutamente no. È un’altra parte del cervello. Poi, le due strade potrebbero correre parallele, ma c’è sempre il rischio di una collisione [parla di alcuni colleghi, non nomina nessuno, che da editor sono diventati scrittori: i casi di estremo successo sono pochi]. A volte, però, mi è capitato di avere delle buone idee e di affidarle alla penna di altri, e in alcuni casi queste idee hanno avuto fortuna. [Sospira]: una parte di me ha rosicato [ma si corregge]; forse rosicato è troppo, ma mi è venuto da pensare che una parte di quella fortuna è sì frutto della scrittura di altri, ma di una mia scintilla. Allo stesso tempo, con l’esperienza impari a estrarre piacere da questa cosa, essere un maieuta nell’ombra. E questo è un altro punto che rende difficile la compresenza di scrittore e editor: lo scrittore vuole esistere, mentre l’editor, se è un bravo editor, lavora per non essere visto. Se lavora bene, le sue tracce sono invisibili, non si riconoscono dall’esterno, e da questa trasparenza trae piacere.
Ad esempio, io ho sempre stimato molto Antonio Franchini. Non solo perché è stato ed è una grande figura editoriale, e una persona brillante e piacevole, ma perché negli anni ha scritto diversi libri, alcuni a mio giudizio bellissimi. Libri che potevano ambire a vendite e riconoscimenti importanti. Lui non ha rinunciato a scrivere o a pubblicare, ma non ha cercato di prendersi la visibilità che pure avrebbe meritato. Io l’ho sempre apprezzato molto, forse uno dei pochi che ha trovato una giusta misura tra le due cose, sacrificandone una parte.
Ci perdiamo per qualche minuto sulle pubblicazioni di Antonio Franchini. Gli dico che poco tempo fa ho letto il suo libro di racconti (Leggere possedere vendere bruciare, per Marsilio), e lui mi dice che Cronaca della fine è un libro strepitoso. Riflettiamo ancora sull’equilibrio fra scrittura e lavoro editoriale. “Forse Franchini non ha rinunciato alla sua parte di scrittore, forse gli bastava scrivere”, gli dico. “Nì”, risponde lui.
S: Scrivere e pubblicare sono due cose diverse. E tutti abbiamo dei file nei nostri computer. Ad esempio, io ho molti appunti sul mio lavoro, presi durante gli anni. Non so cosa ne farò o se sarò in grado di farne qualcosa, ma ci passo le ore: li amplio, ci lavoro.
Guardo la lista delle domande. Alcune le abbiamo attraversate, c’è già una risposta, implicita o meno. Allora ripenso alle interviste di Stefano che ho letto e ascoltato, e decido di uscire un po’ dai binari. Ma neanche troppo.
G: Lavori ancora il legno?
S: No. [Sospira, sbuffa, poi ride. Chissà a chi interessa questa cosa, chiede un po’ a sé, forse un po’ a me. Mi interessa. – Premessa, aggiungo sempre io]: mi appassiono alle cose, mi ci dedico, e a un certo punto mi disamoro completamente e mi dedico ad altro. È successo anche con il legno. [Peccato, dico; e lui sembra pensarci: sì, è vero]. Una volta, a Milano, incontro per strada Chiara Valerio e Michela Murgia. Si soffermano per salutare e mi dicono: “Ho visto le cose che fai con il legno, meravigliose!”, e dentro di me penso: “Cavolo, fra di noi dobbiamo parlare del legno?” [Ride, mi fa sorridere, e mi dimentico di chiedergli a che evento si trovasse]. Ora faccio modellini. Di aerei, carri armati, roba della Seconda Guerra Mondiale.
G: Con la pazienza di aspettare le uscite in edicola?
S: No, [è un no sdegnato] compro i kit. Ma le stesse cose che dicevo nell’articolo sul legno [l’articolo di cui parliamo è questo], in cui cercavo di fare un parallelo fra il lavoro editoriale e quello di falegnameria, potrei farlo anche applicato ai modellini. Sono modi diversi di esercitare la pazienza, la precisione e il pensiero. Se voglio costruire una sedia, per prima cosa osservo molte sedie: guardo i pezzi, capisco le varianti, mi rendo conto di cosa posso fare e di cosa non posso fare, dove sono i limiti tecnici e dov’è la comodità. Così come, se devo lavorare un libro, si presume che ne abbia letti moltissimi, prima. Dopodiché si passa al progetto, e poi ancora cerco di capire quali tecniche posso utilizzare per realizzare ciò che ho progettato. Sbaglio, aggiusto, affino e la volta successiva sono più bravo. Capisco i gesti da fare. Se ti do una sega giapponese in mano, non basta sapere che tipo di lama è e a cosa serve, o solo la direzione del taglio, bisogna anche sapere come utilizzare il proprio corpo. Se tu ti metti a fare così [mima il gesto di un taglio sconclusionato], sbagli, ti fai male. Con il modellismo è lo stesso. Tutto deve essere calibrato e stare al posto giusto, e ugualmente devi capire cosa montare prima e cosa dopo, come dipingerlo per renderlo più realistico: ombre, ruggini, sfumature. E di bello c’è la personalizzazione. Sono modi diversi di sperimentare il piacere artigianale di fare le cose. Lo stesso piacere me lo dà vedere un libro ben riuscito o un aeroplano della Seconda Guerra Mondiale.
Una volta ho costruito un camion russo. Si iniziava montando il motore, tutti pezzettini piccolissimi, da dipingere uno per uno con una vernice diversa, un pennello diverso ogni volta… dopo tre ore di lavoro avevo ottenuto il motore. “Che bello”, ti dici. Dopo un po’, però, ti rendi anche conto che quel motore non si vedrà, sarà circondato dalle lamiere della cabina del camion. Il motore c’è, è perfetto, ma non lo vedrà nessuno. Lo hai costruito perfetto perché ti piace che lo sia. Nell’editing accade la stessa cosa: curi dei dettagli ben sapendo che nessuno se ne accorgerà e che in nessun modo determineranno il risultato finale. Eppure, danno più valore al tuo lavoro, rendono il manufatto migliore.
A volta sembra stupido: pensare che passo ore della mia vita a dipingere un pezzo minuscolo di un modellino di un camion russo, o a sistemare una virgola o un corsivo. Qualcuno potrebbe dirmi “ma dai”, [e mima il celeberrimo gesto del carciofo, o del tulipano – lo chiamava così Gadda in Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana], ma l’importante è ricavarne piacere. E interrogarti, magari, su quel piacere: concentrarti e cercarlo in continuazione. Disamorarti di un lavoro del genere può succedere, piccoli dissapori e frustrazioni che fanno parte del mondo del lavoro in generale, per questo è giusto cercare la radice del piacere che ne ricavi.
Questo lavoro non lo fai per lo stipendio – non ti arricchisci [sorride] – o per il ruolo sociale. L’editor lo fai per il piacere che ne ricavi.
Mi fa riflettere parecchio, questa ricerca del piacere. Non dovrebbe essere così strano associarlo al proprio lavoro, eppure spesso lo è. E allora provo a scavare un po’ di più negli attimi di noia che anche i libri a volte portano.
G: Ti è capitato, nel tuo lavoro, di avere a che fare con testi che, seppur magari oggettivamente buoni, ti hanno annoiato? Di faticare nel portare a termine il lavoro?
S: Certo. Anche se ad oggi capita di rado. Faccio acquisizione: quei libri li ho scelti io e se li ho scelti vuol dire che mi sono piaciuti. Ma delle volte ci sono dei lavori che ti passano meno, questo è vero. “Dovrei farlo in una settimana, ma so che ce ne vorranno tre”. Editare o leggere otto ore al giorno non è umanamente possibile, devi alternare altre cose.
Quando, all’inizio, i libri non li sceglievo io, mi è capitato di lavorare su testi che trovavo brutti o non consoni al mio sentire. Alcune volte è faticoso, e ancora di più se non hai un feeling con lo scrittore o la scrittrice, se non hai la percezione di fare questo lavoro per una persona che ne vale la pena.
G: E quanto tempo impieghi, in media, per un editing? Di quelli che ti piacciono, si intende.
S: Non lo so. Dipende dai testi, e poi faccio anche altre cose: leggo, acquisisco, mi occupo di cose che non hanno a che fare con il testo e curo molto gli autori. L’editing mi capita di farlo in treno, di mattina, o in pausa pranzo – tutti i miei colleghi escono e ho un’oretta di silenzio. Oppure alla sera dopo le sei, quando c’è più quiete e i messaggi diminuiscono. Lo strano è che, a conti fatti, sia la lettura sia l’editing spesso e volentieri te li devi ritagliare a margine di una routine lavorativa che ti porta a fare altro.
G: La lettura che fai per piacere è diversa dalla lettura che fai con i manoscritti di lavoro?
S: Sì. Spesso, un romanzo italiano non riesco a leggerlo con serenità: conosco l’editore, le persone che hanno lavorato al libro, l’autore o alcune cose sull’autore, il dibattito su quel romanzo. Troppi elementi esterni che mi influenzano e mi tolgono piacere. Preferisco svagarmi davvero, e allora leggo altro, soprattutto saggistica. Ma magari fra qualche anno cambio gusto.
G: Mi consigli un saggio?
S: Sto leggendo molto sulla storia dell’editoria. [Solleva un libro ingiallito, una di quelle edizioni che odorano di naftalina. Leggo: Storia e idee di un editore vivente]. Attilio Vallecchi, un libro del 1935. Queste sono le mie letture [ride]. La saggistica ti fa appassionare a saperi fuori dalla tua comfort zone. [Alza gli occhi, cerca di ricordare il titolo di un libro, poi lo trova]: Il controllo della Natura di John McPhee. Lo cito spesso: una parte molto consistente del libro parla del sistema di chiuse che regolano l’afflusso di acqua del Mississippi, in Louisiana. Una cosa lontanissima: “che me ne dovrebbe fregare?” ti dici. Ma se lo leggi è appassionante. E dello stesso autore, un libricino che si intitolava Tennis, di una trentina di anni fa, in cui si racconta una partita tra due tennisti famosi degli anni Sessanta… quella partita, raccontata giornalisticamente, è anche lo spunto per raccontare il periodo, la società, tanti contrasti, la magia di quello sport. Quando la saggistica è fatta bene, quando non è il classico manuale o non è di vecchio stampo iper didattico, ha la capacità di aprire una finestra su un pezzo di mondo e poi farti esplodere lo sguardo. E si rivela molto utile per chi fa narrativa: guardarsi intorno, avere competenze disparate, ci aiuta. Anche per uscire da tutti questi libri di paranoie borghesi o sentimentali: molta narrativa italiana ha uno sguardo ristretto, avvitato su questi temi.
G: Ne approfitto: è vero che la narrativa italiana pecca di trama?
S: Dipende. Il letterario sì. I cosiddetti letterari sembra che per la maggior parte abbiano trame abbastanza pretestuose. E forse va bene così. “Un libro è ciò che rimane dopo che l’hai spellato della trama”, non ricordo chi lo ha detto ma è un’immagine che trovo stupenda: la trama è un vettore, e se si togliesse, come una pelle, quanto ne rimarrebbe all’interno? Che cosa? O, meglio, ci sarebbe qualcosa? A me non piacciono, per esempio, i libri di sola trama. Non mi piacciono perché, alla fine, non mi lasciano molto. Anche nell’intrattenimento, tolta la trama dovrebbe restare qualcosa: un personaggio, un tempo, una lingua, una riflessione su un tema, uno sguardo su qualcosa.
G: Gli aspiranti, ad esempio, spesso tentano l’originalità solo nell’intricato della trama. Una delle mie frasi preferite, già che siamo in tema di citazioni, è di Asha Dornfest: “I giovani scrittori hanno paura che tutto sia già stato scritto. Sì, lo è stato, ma non da voi”.
Stefano annuisce e mi racconta di alcuni laboratori che tiene nelle scuole con l’associazione Centro formazione supereroi. I ragazzi delle medie si fanno le stesse domande, hanno la stessa paura, mi dice. “Io cosa devo dire in più? si chiedono. E noi cerchiamo di spiegare che ognuno possiede una porzione di verità: la luce che proietta su quella porzione di verità è diversa da un’altra, è unica, originale. E questo vale anche per gli adulti. Nessuno sarà più il primo a raccontare l’adolescenza, l’amore, il crimine, ma ognuno ha una parte importante e unica da illuminare.”
S: Agli scrittori aspiranti o dilettanti mi capita spesso di chiedere “di cosa parla il tuo libro?” Di solito iniziano a raccontare la trama. Li fermo e pongo di nuovo la domanda: “di che cosa parla il tuo libro?” Il libro non parla della trama, ma di qualcosa che ti interessa raccontare e che si trova sotto la trama. Si può anche partire senza sapere che cosa si vuole raccontare, ma a un certo punto la domanda deve nascere spontanea: perché sto raccontando questa storia?
Da poco sono stato a un gruppo di scrittura. C’era un ragazzo talentuoso ma molto confuso che aveva scritto una cosa inconcludente, debole. Lo abbiamo stimolato a capire cosa volesse raccontare, e lui ci ha dato delle spiegazioni alte, tanti riferimenti culturali. Non mi ha del tutto convinto, e allora gli ho chiesto: “perché ti importa raccontare questa cosa?” Non ha saputo rispondere, non era importante per lui. Ecco il punto: non sapeva dove stava andando, per questo non arrivava da nessuna parte. E se non è importante per chi scrive, allora non lo sarà neanche per i lettori.
G: Natalia Ginzburg ci dà una verità per me assoluta, che la scrittura e le parole si cercano dentro di noi, non al di fuori. E lo stesso ci dice Antonella Cilento ne La caffettiera di carta: quando decidi di iniziare a scrivere tutto ciò che puoi scrivere ce lo hai già dentro, ti è già successo. E invece penso che molti aspiranti abbiano la tendenza a voler prendere da fuori qualcosa che, non possedendo, non conoscono. E se non conosciamo qualcosa non ci importa. E allora non si arriva da nessuna parte.
S: [Annuisce] Forse è un’impostazione che ci viene dalla scuola, per questo è utile dire ai ragazzi: “voi siete preziosi con il vostro sguardo e la vostra interiorità”.
G: A me non è stata mai detta una cosa simile quando ero a scuola.
S: Certo che no.
Mi racconta qualche altro aneddoto sui laboratori con i ragazzi. Mi parla di un bell’esercizio in cui si chiede loro di scrivere la propria biografia. Partono raccontando dove sono nati, se hanno fratelli o sorelle, dove vivono. “E poi? Cosa ti piace?”; con il Centro formazione supereroi li spronano a scavare di più, a raccontarsi.
S: Quando scrivi, puoi anche partire dal di fuori. L’importante è che ti serva per tornare a te, a dentro. Ma senza raccontare gli affari tuoi [l’espressione è più colorita, ridiamo].
G: Questa ultima tendenza all’autofiction.
S: Esatto. Anche se dipende da come lo fai. Emanuele Trevi, quando racconta del rapporto con suo padre, lo fa in una maniera talmente eccezionale che non sono solo “i fatti suoi”. Altri libri… [al contrario, aggiungo io].
G: Lo dicevamo prima. In editoria un filone può avere successo, ma dopo un po’ tende a esaurirsi, partorendo solo brutte imitazioni dell’originale.
S: Il vero talento – di tutti: editori, giornalisti, scrittori – dovrebbe essere quello di sapere prima dove sarà l’interesse. Quanto ti infili in una moda non sei destinato al successo che desideri davvero. Se ci fai caso, tutte le volte che prende piede una moda, il primo libro ha grande successo, ma i successivi non lo superano mai.
G: Hanno solo le copertine simili.
S: Sì. È chiaro che anche io devo assecondare le regole di mercato, è un mio dovere. Ma per avere successo, ogni tanto devi cercare di cambiare strada, e poi speri che la fortuna ti baci. Insomma, una cosa che raramente si dice è che nel nostro lavoro nulla vale più della fortuna. Sì, il talento ci deve essere, ma la fortuna… [solleva le spalle: è una certezza ineluttabile].
Sul tema della fortuna con i libri, con i prodotti culturali e no – con tutto, in realtà, con la vita – mi areno per qualche secondo. È trascorsa un’ora e mezza dall’inizio dell’intervista, ho ancora poco tempo per evitare che Stefano inizi a pensarmi insopportabile. Lancio uno sguardo alla lista delle domande. Gli chiedo cosa ne pensa dei generi, di cosa si occupa principalmente. Mi parla dei gialli, si dice sorpreso della loro resistenza, del loro stampo che si ripete quasi uguale. “Sono sempre in classifica. I lettori sono molto fedeli”. Dice di amare questo genere.
S: Ultimamente vedo spesso il cozy crime. Un’etichetta per identificare qualcosa che secondo me esisteva già.
G: La classificazione di generi e sottogeneri serve solo al mercato, no? Non agli scrittori.
S: A chi scrive non serve a nulla. Serve ai lettori – i lettori di questi generi sono davvero fedeli, come mio papà. Li legge da quarant’anni, e per me è come se leggesse sempre lo stesso libro [sorride]. Ma lo faccio anche io. È come andare a mangiare la pizza: è pizza, e ti piace sempre.
E poi i generi servono per i librai. Ne hanno bisogno per avere a che fare con i loro clienti, e l’etichetta è uno strumento utile per il loro lavoro. Chi scrive, invece, dovrebbe fregarsene, almeno un pochino. Chiarisco il “pochino”: chi scrive dovrebbe sempre studiare il mercato, conoscere il territorio in cui si muove, altrimenti è come andare al casino senza conoscere alcuna regola del gioco. Se scrivi un giallo ma ne leggi pochissimi, e non sai quali sono gli stereotipi di genere, gli elementi ricorrenti, rischi di ripeterli in maniera pedissequa oppure di ignorarli tutti: sono entrambe cose sbagliate. Bisogna conoscere il canone per rinnovarlo.
G: Questo è un discorso che vale per tutti i generi.
S: Certo. Anche per il letterario, più svincolato. Se, per esempio, oggi vuoi scrivere un’autofiction devi aver letto quelle più importanti degli ultimi anni.
G: Sembra una banalità. Leggere per scrivere, leggere per conoscere il genere. Eppure, è una cosa che spesso non si fa.
S: Il problema, Gloria, detto terra-terra, è che tante persone vogliono diventare scrittori, ma leggere è faticoso. È un impegno, a volte una rottura.
G: [sorrido, mi viene in mente un libro]. Un pamphlet molto bello, di Vanni Santoni, La scrittura non si insegna, ci offre una “dieta di lettura”.
S: [Stefano sospira, si allontana e si avvicina dall’inquadratura] Cosa ne pensi tu?
G: Si deve leggere, ma non penso esista una lista definita o definitiva.
S: [Annuisce] Vanni è geniale, ma fa una selezione che metterebbe in difficoltà chiunque. Scrivere è come uno sport: inizi con le cose più semplici e con il tempo migliori e affronti quelle più complesse.
G: Chiaramente, questo quando siamo adulti. Se avessimo una cultura del leggere già da bambini, tutto sarebbe più semplice.
S: È il problema della scuola italiana. Ti fanno leggere Foscolo, Carducci, Manzoni. E poi si stupiscono se un ragazzino dice che leggere è una rottura. E l’alternativa non deve per forza essere il pattume commerciale: ci sono tanti libri accessibili che stimolerebbero l’amore per la lettura senza che debba avere le sembianze di uno sciroppo per la tosse.
L’amore per la lettura l’ho scoperto all’università. Non prima. Quando ho avuto la fortuna di avere insegnanti che facevano programmi di letteratura contemporanea ho scoperto che il massimo della goduria non era Il barone rampante. Il problema è che la scuola ti insegna che ci sono solo i classici. E nessuno ti dice che leggere è divertente, che non è tanto diverso da correre in un prato o ballare. E ha lo stesso valore.
G: Anche il rapporto con l’oggetto-libro è distante, eccessivamente rispettoso. Molti lettori tengono i libri intonsi. C’è chi non apre troppo il libro per non rompere la costa.
S: Anche io.
Mi stupisco! “Anche tu!”. “Adesso meno, però” mi dice. “Non scrivi sui libri?” gli chiedo.
S: Dipende. Scrivo ma in maniera molto ordinata. [sorride, rido anche io] È feticismo. Ma quello che dicevi è giusto: avere troppo rispetto della letteratura, quella che ti insegnano a scuola, non fa bene alla lettura. Se metti la letteratura in un tempio la poni a una distanza eccessiva dalle persone.
G: Inizia anche a fare paura.
S: Sì. Inizia a sembrare una cosa per la quale devi essere all’altezza. Invece, sei già all’altezza di poter leggere e di scegliere cosa ti da piacere. Perché a scuola non si leggono i narratori degli ultimi venti o trent’anni? Perché non si leggono Tondelli, Brizzi o tante altre cose più recenti?
Durante il lockdown mi è venuta voglia di leggere I Promessi Sposi. Li ho letti con una consapevolezza e una sensibilità linguistica che trent’anni fa non avrei mai potuto avere. E soprattutto per scelta, per piacere. E per la prima volta mi sono reso conto della grandezza di questo romanzo. Come può capirlo un ragazzo o una ragazza di quindici anni che non ha gli stessi strumenti? Impossibile. O come può capire una poesia se la si fa con parafrasi, note… tutto ciò che toglie piacere. O, per lo meno, non tutti i ragazzi possono farlo.
Ho un’ultima domanda, ma non so in quante si trasformerà.
G: L’editoria si dà per morta ogni anno, ogni giorno, da sempre. Si dice che il mondo dell’editoria sta crollando. Tu cosa ne pensi? Mi sembri più ottimista.
S: Se non lo fossi correrei a cambiare lavoro. L’editoria è un amore, ma è anche una necessità: è il mio lavoro. [Ci pensa un po’, poi mi risponde] È un vezzo degli editori, sentirsi vicini a un baratro irreparabile. Leggo molta storia dell’editoria, memorie di editori, carteggi, anche cose datate, e trovo in continuazione frasi che sembrano dette oggi. Mi fa pensare: noi ci sentiamo speciali, forse speciali anche nell’essere quelli più prossimi alla “catastrofe annunciata”… in realtà, è sempre stato così. Il mondo esterno è cambiato, cambierà, ma negli anni tutti i tentativi di fare a meno degli editori sono falliti. Ad esempio, il selfpublishing che sembrava dover far fuori la mediazione editoriale, si è dimostrato un modello alternativo. Mi piace o non mi piace, non è questo il punto.
G: Ti piace o non ti piace?
S: No, nel complesso non mi piace. L’assenza di filtro non è un buon servizio per il lettore.
G: Non tutti, ma molti vengono mediati comunque. Per gli autori è costosissimo, è una scelta. Passano da editor esterni, grafici esterni, correttori di bozze esterni, uffici marketing…
S: È esattamente dove volevo arrivare. In definitiva, il servizio di mediazione serve comunque. Le case editrici come esistono oggi non sono sempre esistite, quindi in futuro è quasi certo che ci sarà un’organizzazione diversa e può anche darsi che gli editori così come li conosciamo non esisteranno più, ma la funzione editoriale rimarrà. Non se ne può fare a meno. Serve qualcuno che ti aiuti a costruire un ponte fra te e i tuoi lettori. La mediazione esiste anche in altri settori. Sui servizi in streaming, ad esempio. Prendi Netflix. Sembra una cosa democratica, dove tu sei libero di scegliere la serie tv o il film che preferisci, ma in realtà lì qualcuno ha già scelto per te: testi, locandine, consigli, pubblicità. E tu sei contento di avere quel servizio, perché se non ci fosse la mediazione, se fosse solo un elenco infinito, non riusciresti a districarti. Tutti vogliamo abbondanza, ma non caos.
G: E già così è caotico.
S: Come in libreria. Tu entri e se non hai qualche indicazione non sai dove girarti.
G: È vero che i libri a scaffale, messi di costa, quelli che devi leggere così [piego la testa di lato] sono libri quasi persi?
S: Eh, sì. Penso di sì. Se il lettore che entra in libreria sa cosa vuole, la troverà. Se il lettore entra in libreria per fare un giro, difficilmente si metterà con la testa inclinata. È più facile quindi che si guardino le novità [messe di piatto, quelle esposte sui banchi]. Ma lo stesso succede su Amazon: o sai cosa vuoi oppure, se non lo sai, al massimo puoi cercare per categorie. E magari finisci che compri i libri in classifica o quelli che ti suggerisce l’algoritmo.
G: E qual è la vita media di una novità? Un mese?
S: Sì, più o meno. I libri per ragazzi hanno una vita media più lunga, per esempio, perché i meccanismi delle novità hanno una maggiore durata, resistono al tempo, se fatti bene. I libri per adulti, invece, se non partono subito possono sparire in poche settimane.
G: Perché l’editoria punta a un ricambio aggressivo piuttosto che a una promozione maggiore? Non sarebbe più semplice avere meno libri ma promossi molto di più? Magari anche in maniera innovativa?
S: Obiezione sacrosanta e che anche noi spesso ci facciamo. Ha senso. Ma all’atto pratico non è realizzabile. Si dice sempre “marketing innovativo”, ma ne vedo raramente: il libro è un prodotto che si presta poco a un marketing innovativo. Sì, puoi inventare qualcosa: gadget, eventi… ma non è un modello, è uno one shot. Il marketing editoriale è molto complesso. Inoltre, non si produce meno perché il meccanismo va alimentato: se hai un’azienda che pubblica dieci libri e questi vendono dieci copie l’uno, in un anno avrai venduto cento copie. L’anno successivo ne vuoi vendere centodieci. Come fai? Il modo più semplice è pubblicare undici libri. E non si torna indietro. Sarebbe necessario che tutto il mercato riducesse la produzione, non il singolo. E il mercato risponde al pubblico, e il pubblico vuole la novità. I librai hanno bisogno di alimentare il proprio negozio, la distribuzione ha bisogno di movimentarsi finanziariamente. È irreversibile, un meccanismo cancerogeno: produci sempre di più.
Un po’ di numeri: alla fine degli anni Novanta le novità pubblicate in Italia erano circa ventimila; una decina di anni fa erano poco più di cinquantamila. Fra il 2021 e il 2022 erano ottantacinquemila. In vent’anni sono quadruplicate. La soluzione sarebbe una diversa armonia culturale e sociale, oppure un trauma: se un domani il mercato sprofondasse, allora si potrebbero cambiare i meccanismi di produzione. Non c’è da augurarselo, però.
Stefano mi consiglia un reportage di Dino Buzzati degli anni Trenta. Già si lamentava della sovrapproduzione che andava a rovinare la qualità. “Ci scommetti che in cinque anni, o prima, si arriverà a centomila novità?” mi dice.
S: E anche in questo, il selfpublishing, che aumenta ulteriormente la proposta, fa bene o fa male? Forse fa male.
Guardo l’orologio, sono trascorse più di due ore. Mi scuso con Stefano per averlo trattenuto così tanto. “Se mi dai il via non mi fermo” mi dice. “Anche io”. Lo ringrazio. Mi ha fatto molto piacere.
G: Non ho nessuna domanda di chiusura a effetto.
S: [Sorride] Se mentre metti mano a queste cose ti viene in mente qualcosa, scrivimi.
Fuori non pioviggina più. Il caffè si è raffreddato. È venerdì, non ho nulla da fare. Mi alzo per sgranchirmi le gambe, accendo una sigaretta. Guardo la mia biblioteca domestica e inclino la testa di lato per cercare qualcosa da leggere.
Stefano Izzo lavora in editoria dal 2005. Attualmente è editor senior per Salani Editore. Nel 2019 ha ricevuto il premio come miglior editor italiano. È docente di professioni editoriali per la Fondazione Mondadori, l’università di Pavia e la scuola Belleville di Milano.
*